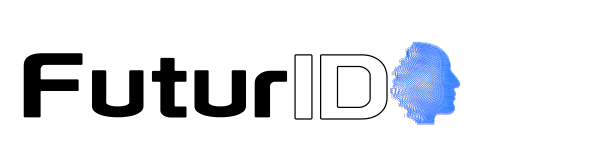Quante specie ci sono sul pianeta?
Per misurare la diversità della vita, ma anche la perdita di biodiversità, conoscere il numero di specie presenti sul nostro pianeta sembra cruciale. Tuttavia, rispondere a questa domanda è molto più complicato di quanto sembri.
Dopo le numerose spedizioni naturalistiche, che dal XVI al XIX secolo hanno esplorato il pianeta alla scoperta della straordinaria diversità delle specie che lo abitano, la questione del numero esatto di specie esistenti sul pianeta sembrava secondaria. Ma dall’inizio del XXI secolo, con l’accelerazione degli effetti deleteri delle attività umane sull’ambiente e la consapevolezza di un declino della biodiversità, questa questione è tornata in discussione. Su una Terra malata, dove le specie scomparirebbero a un ritmo troppo elevato, conoscere esattamente il numero di specie presenti sulla superficie del pianeta è come prendere la temperatura del pianeta. E specificare a quale entità e velocità questo numero varia, è come valutare la gravità di un sintomo della crisi ecologica. Tuttavia, monitorare il numero esatto di specie sul pianeta è una sfida sotto molti aspetti.
Indice
Una sfida enorme: elencare milioni, se non miliardi, di specie
Nel XVIII secolo, il naturalista svedese Carl von Linné inventò la tassonomia: la scienza che descrive e classifica la diversità della vita in gruppi (i taxa) e assegna loro un nome. La classificazione è gerarchica e l’unità più piccola è la specie. Nei suoi famosi libri Systema naturae e Species plantarum, Linné classifica e nomina circa 12.000 specie di animali e piante. Un lavoro esaustivo su tutte le specie conosciute dell’epoca che era allora realizzabile da un solo autore, anche se gli storici ci ricordano che era aiutato.
All’inizio del XX secolo, la spedizione naturalistica Santo 2006 inaugura il programma di riscoperta della natura “La planète revisitée” promosso dal Museo nazionale di storia naturale. Obiettivo: fare un inventario esaustivo della diversità delle specie in diverse regioni del mondo. La spedizione ritorna dall’isola di Espiritu Santo, di soli 4.000 km² di superficie nell’arcipelago di Vanuatu nell’Oceano Pacifico, con un inventario di circa 10.000 specie. Quasi quante ne aveva catalogate Linné! E ci sono voluti più di 150 scienziati di tutto il mondo, con l’aiuto di 100 membri del personale di supporto e accompagnatori, che hanno soggiornato cinque mesi sull’isola, per raggiungere questo risultato.
Il numero totale di specie conosciute è infatti aumentato notevolmente. Nel 2024, l’elenco di tutte le specie conosciute conta 2.153.938 specie. Si tratta principalmente di animali invertebrati, con 1.489.932 specie, di cui per lo più insetti con 1.053.578 specie. Gli animali vertebrati contano (solo) 75.923 specie, le piante 425.679 specie, i funghi 157.648 specie. Contarle tutte è diventato una sfida, che richiede un lavoro necessariamente collettivo, coinvolgendo specialisti delle diverse categorie.
Questa lista globale, che testimonia già della straordinaria diversità delle specie, è tuttavia incompleta: secondo l’opinione generale, una parte significativa delle specie che popolano la biosfera è ancora sconosciuta. Ce ne sarebbero molte di più. Le stime recenti del numero totale di specie esistenti oscillano tra 8 milioni e diversi miliardi. Pertanto, le specie di invertebrati esistenti sarebbero da 3 a 100 volte più numerose di quelle già descritte! Potrebbero esistere quasi 4 milioni di specie di funghi! Mentre oggi si conoscono da 10.000 a 30.000 specie di batteri, ce ne sarebbero miliardi! Ma come fare per catalogarle tutte?
Una sfida pratica: identificare e contare le specie che non sono mai state viste
Il metodo classico per scoprire nuove specie durante gli inventari naturalistici, ispirato da Linné, si basa sull’osservazione diretta: sul campo, gli individui vengono raccolti, descritti e classificati in base alle loro caratteristiche morfologiche. Se la descrizione è inedita, viene creata e nominata una nuova specie e la sua descrizione viene pubblicata con riferimento a un campione tipo conservato in un museo. Ciò richiede quindi un lavoro considerevole per aggiungere una sola specie alla lista delle specie conosciute. Dato il divario tra il numero di specie conosciute e quello delle specie esistenti, è chiaro che questo approccio non sarà sufficiente per completarlo.
Ma due metodi moderni permettono di avanzare a passi più grandi.
Uno permette di identificare le specie senza vederle. Con gli strumenti della biologia molecolare, è possibile contare le specie a partire dalle tracce di DNA che lasciano nei loro habitat. Questo è chiamato DNA ambientale. Basata sul sequenziamento di tutti i frammenti di DNA trovati in un determinato ambiente, questa tecnica, chiamata barcoding, consiste nell’utilizzare le differenze genetiche tra le specie. Ogni sequenza rilevata dal DNA ambientale è associata alla presenza di una specie, che sia già descritta o meno.
L’altro metodo consiste nell’estrapolare le conoscenze già disponibili sulla biodiversità per stimare un numero totale di specie. Alcuni autori suggeriscono, ad esempio, di utilizzare il numero di gruppi conosciuti a livelli tassonomici superiori alla specie per stimare un numero totale di specie. Quindi, se si conoscono i numeri di classi (ad esempio, i mammiferi), ordini (ad esempio, i carnivori), famiglie (ad esempio, i canidi) e generi (ad esempio, Canis) di animali, si dovrebbe poter stimare un numero di specie animali. Altri autori suggeriscono di ipotizzare che ogni specie animale conosciuta sia l’ospite esclusivo di un numero medio di parassiti o simbionti animali, sconosciuti, per stimare un numero totale di specie animali di parassiti o simbionti.
Questi metodi sembrano adeguati per contare meglio le specie sul pianeta… finché non ci si interroga su cosa sia una specie! E qui il problema si complica!
Una sfida teorica: alla fine, cos’è una specie?
Per contare frutta e verdura, bisogna prima sapere cosa sia un frutto o una verdura. E questo non è sempre scontato. Il pomodoro, ad esempio, è un frutto per i botanici, una verdura per i cuochi. Il problema è ancora più complesso per le specie. Cosa si conta esattamente? Il concetto di specie deriva infatti da una visione ideologica dell’organizzazione del mondo vivente. Suggerisce l’esistenza di unità ben separate, le specie… che è poi molto difficile definire.
Nell’approccio naturalistico classico, sono le differenze visive che permettono di distinguere una specie dall’altra. Questo approccio aderisce al cosiddetto concetto “morfologico” di specie. Va bene, ma a partire da quale livello di differenza morfologica si può concludere che gli individui appartengono a specie diverse? Non ci sono regole.
In confronto, il concetto “biologico” di specie pone l’accento sull’integrità genetica di gruppi di individui tra i quali gli scambi genetici sono impediti da barriere alla riproduzione sessuale. Va bene, ma bisognerebbe sempre osservare i risultati degli incroci per concludere che gli individui appartengono a specie diverse? È ovviamente impossibile durante le spedizioni naturalistiche, quando i casi dubbi si presentano a decine, se non di più.
Il concetto “evolutivo” considera le specie come entità che evolvono separatamente l’una dall’altra. Secondo questo concetto, una specie è una linea genealogica genitori-discendenti isolata da altre linee dello stesso tipo. Ciò che accade in una linea è indipendente da ciò che accade nelle altre. È il concetto più inclusivo. Va bene, ma come lo si testa, specialmente quando non si conosce la storia degli individui della generazione attuale? Attraverso studi genetici, costosi e talvolta difficili da realizzare.
Questi concetti concorrenti dividono la comunità scientifica. Per i biologi sul campo, i concetti biologico ed evolutivo, troppo teorici, sono inoperanti. Per i microbiologi, interessati a organismi unicellulari che presentano pochissimi caratteri visibili (anche al microscopio), ma che scambiano materiale genetico attraverso la coniugazione batterica, i concetti morfologico e biologico sono inadeguati.
Questi concetti sono generalmente compatibili: gruppi geneticamente isolati dovrebbero evolversi indipendentemente e divergere morfologicamente. Ma le eccezioni ne sottolineano l’incompletezza. Si conoscono, ad esempio, coppie di specie, dette criptiche, che sono morfologicamente indistinguibili ma che evolvono indipendentemente. In Francia, si è recentemente scoperto che esistono due specie criptiche di talpe: la talpa europea, che si pensava fosse unica e distribuita in tutta la Francia e in Europa, e la talpa aquitana, che è stata finalmente riconosciuta come un’altra specie, a sud e a ovest della Loira.